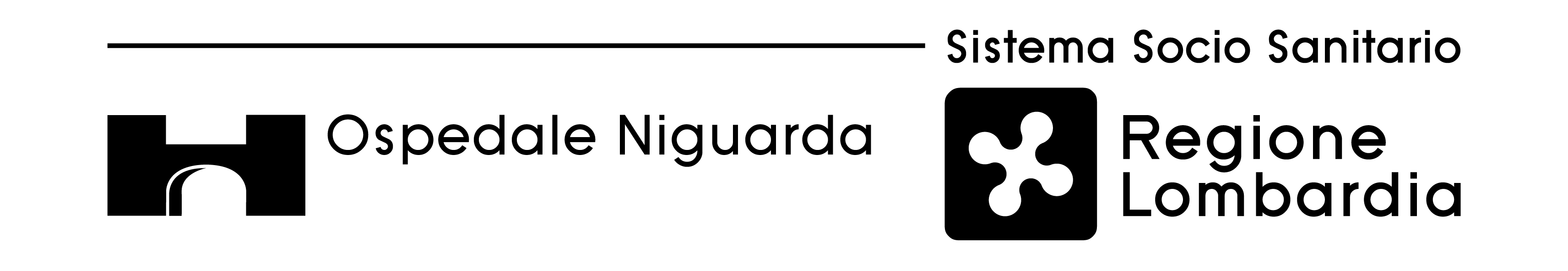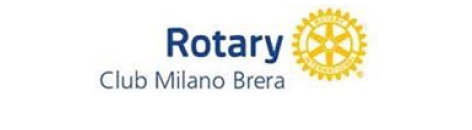Nell’alimentarsi c’è da considerare un forte aspetto legato alla socialità: si tratta infatti di una pratica con risvolti conviviali, di socializzazione e di affiliazione tra le persone. Basti pensare, in tal senso, alla condivisione di eventi più o meno importanti che si fa attraverso il cibo: compleanni, feste, celebrazioni religiose o tradizionali, matrimoni, funerali, traguardi accademici, e così via.
Dalla scansione della nostra quotidianità, in cui abbiamo i pasti giornalieri che costituiscono un significativo punto di riferimento, alla presenza in occasioni speciali e nei più svariati contesti di vita (familiari, lavorativi), il cibo accompagna tutta la nostra esistenza risultando un importante moderatore del benessere, delle relazioni e delle emozioni.
Secondo l’etimologia latina del termine, infatti, mangiare è inteso sia concretamente come appagamento di un bisogno, ossia quello di soddisfare la fame, sia nel senso più simbolico di convivio, piacere, rifugio, consolazione.
La valenza emotiva del cibo, da un punto di vista psicologico, si può comprendere facilmente pensando al significato affettivo che per ciascuno di noi può assumere, ad esempio, la pietanza particolare che preparava una persona importante, il dolce preferito di quando eravamo bambini, lo spuntino che facevamo il pomeriggio con gli amici. Al cibo, dunque, attribuiamo significati importanti che fanno parte della nostra storia di vita e creiamo con esso un legame mnemonico e affettivo, che affonda le radici nel passato ma resta per sempre capace di rievocare quelle sensazioni così gradevoli e appaganti.
Esiste dunque una strettissima relazione tra la sfera affettivo-emotiva e l’alimentazione.